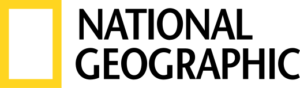La storia di Argil, l’uomo di Ceprano. Ritenuto a lungo il più antico fossile umano italiano, in realtà è più recente di quando si pensasse. Ciò lo rende meno interessante? Tutt’altro.
di Stefania Martorelli
per National Geographic Italia
*
Un cacciatore di elefanti. O almeno così vogliamo immaginarlo, mentre scheggia amigdale affilate all’ombra dei vulcani che riscaldano la sua terra; o, più probabilmente, acquattato fra le felci, in attesa che un grosso felino abbandoni la sua preda per finire di ripulirla. È un buon posto quello che ha scelto per vivere: è ricco di animali – come elefanti appunto, cervi, daini, rinoceronti – di acqua, di grotte in cui trovare rifugio; anche se, di tanto in tanto, la terra trema e quei vulcani eruttano.
Ma poi accade qualcosa, qualcosa che forse non sapremo mai. Lui cade in acqua. È una fortuna, per noi, perché le iene non lo vedono, e l’argilla lo protegge. Altri, più evoluti, arrivano e prendono il suo posto, mentre su di lui si accumulano, strato dopo strato, i millenni, a centinaia. E intanto intorno tutto cambia, finché un giorno, durante i lavori di costruzione di una strada, una ruspa scava il terreno e le ossa sbriciolate del suo cranio (o meglio del suo “calvario”, al reperto manca del tutto la faccia) catturano l’attenzione di un altro cacciatore, ma di antichi resti stavolta, che si chiama Italo Biddittu. Siamo nel marzo 1994, e l’Uomo di Ceprano, il più antico e forse più importante fossile umano italiano, è finalmente tornato alla luce.
Ma quanto è antico l’Uomo di Ceprano? Per oltre un decennio, quel fossile rinvenuto in mille frammenti, montati e smontati più volte, che deve il suo nome a una località fino ad allora nota soprattutto per l’uscita dell’autostrada Roma-Napoli, contende ad alcuni reperti ritrovati ad Atapuerca, in Spagna, e battezzati Homo antecessor, il titolo di primo abitante d’Europa. Così almeno la pensano mostri sacri della paleontologia italiana come Aldo Segre, geologo, e Antonio Ascenzi, anatomopatologo, che fanno risalire quel reperto a 900-800 mila anni fa.
«Del resto, la morfologia arcaica del fossile sembrava confermarlo», dice Giorgio Manzi, antropologo dell’Università La Sapienza di Roma che per due anni, a partire dal 1999, studia il cranio assieme al “mitico” Ascenzi. «È un reperto straordinario, ma estremamente enigmatico. La struttura ricorda una forma umana estinta nota in Asia come Homo erectus, e mai identificata in Europa con altrettanza evidenza; ma nel dettaglio presenta invece tratti molto più evoluti». Francesco Mallegni, antropologo oggi in pensione dell’Università di Pisa, ascrive addirittura quel reperto a una specie nuova, che battezza, fra lo scetticismo di molti, Homo cepranensis.
Passa qualche tempo, e all’inizio degli anni 2000 Manzi, Biddittu e altri studiosi, con la supervisione di Annalisa Zarattini della Soprintendenza Archeologica del Lazio (Ascenzi nel frattempo è scomparso), riprendono a scavare a Ceprano, anzi, a Campogrande, come si chiama la località in cui è stato ritrovato il fossile. E a questo punto la storia prende ancora un’altra svolta.
Gli scavi, in questa zona, hanno una lunga tradizione. Da decenni l’area attorno a Ceprano, Pofi, insomma tutta la Valle Latina, o del Sacco, è una fonte inesauribile di reperti antichi. «Potrebbe quasi essere considerata come una sorta di Atapuerca, in Spagna, o di Middle Awash, in Etiopia», dice Manzi. Lo testimonia la ricca collezione di quel gioiellino misconosciuto che è il Museo preistorico “Pietro Fedele” di Pofi, di cui è l’anima lo scopritore dell’Uomo di Ceprano e di molti altri reperti, Italo Biddittu, archeologo dell’Università di Cassino.
La sua scoperta del cranio non è casuale: Biddittu batte queste aree dal 1958, quando arriva qui attratto dai ritrovamenti di ossa e strumenti litici effettuati dall’allora sindaco di Pofi, quel Pietro Fedele archeologo per passione a cui oggi è intitolato il museo della cittadina. E che un anno dopo, nel 1959, è artefice di una scoperta straordinaria. «Chiamati da Fedele», racconta Biddittu, «a Pofi erano venuti due grandi studiosi, Luigi Cardini dell’Istituto italiano di Paleontologia umana, e Alberto Carlo Blanc, direttore dell’istituto, a esaminare i reperti trovati nella cosiddetta Cava Pompi. Per prima cosa, Blanc compra due lampadine da 100 candele, per poterli esaminare meglio, e a quella luce Cardini inizia a elencare: “Cervo, rinoceronte, elefante… Homo!”. In quel mucchio di ossa c’erano infatti un’ulna e una tibia umane, note come l’Uomo di Pofi, che in seguito furono datate attorno a 350 mila anni fa».
Perciò quando Biddittu, quasi cinquant’anni dopo, va a vedere lo sbancamento per la costruzione della strada, sa già che quell’area è un giacimento di possibili ritrovamenti. Vent’anni prima infatti, nella zona di Colle Avarone, proprio di fronte a Campogrande, erano stati individuati siti che hanno restituito vari strumenti antichi. E proprio lì, in uno strato d’argilla, fa la scoperta di una vita, i frammenti del cranio miracolosamente scampati alla ruspa che lui battezza affettuosamente “Argil”.
Gli scavi condotti a Ceprano dopo il 2000 confermano però un suo iniziale sospetto, e cioè che il cranio non abbia 8-900 mila anni, ma che sia molto più recente: non più di 430 mila anni. («Lo strato d’argilla in cui si trovava il cranio era proprio sotto quello dei bifacciali, stimati attorno a 250 mila anni fa», ricorda). Il fossile dunque non è molto più antico del cosiddetto “Uomo di Pofi” (in realtà l’ulna e la tibia appartengono probabilmente a un individuo di sesso femminile) ritrovato nel 1959. Addio “abitante più antico d’Europa”.
«Ci siamo dovuti arrendere all’evidenza dei dati forniti dal paleomagnetismo, dalle evidenze paleobotaniche e da molte altre analisi», racconta Manzi. «E allo stesso tempo abbiamo finalmente potuto ricostruire la storia geologica dell’area di Campogrande, con una stratigrafia arrivata a 60 metri di profondità, dove vediamo un grande bacino lacustre che ai tempi del nostro uomo si stava ritirando; e dove abbiamo ritrovato i resti di un elefante».
Ma la nuova datazione rende il fossile meno interessante? Secondo Manzi, è vero il contrario. «Quel cranio ci dice una cosa molto importante, e cioè che la storia dell’evoluzione umana avvenuta nel nostro continente attorno a 400 mila anni fa è molto più complessa di quello che pensavamo, fra le popolazioni mediterranee c’è molta più variabilità; la strada che segue non è un percorso lineare che porta dritto all’Uomo di Neandertal. La ragione principale sta proprio in quella natura “duplice”, da Giano bifronte, del fossile: la sua architettura, l’impalcatura se così vogliamo dire, guarda al passato, a specie umane molto più antiche, mentre il dettaglio, i caratteri fini, guarda ai suoi contemporanei europei, e cioè Homo heidelbergensis.
E non c’è nulla in lui che parli di Neandertal. Ma Ceprano ha qualcosa in più, che è appunto quella morfologia così antica. Non conosciamo ancora l’antenato di H. heidelbergensis, una specie umana soggetta a grande variabilità a livello locale, ma certamente Ceprano è il miglior candidato attualmente in circolazione adatto a rappresentare quell’antenato».
E con questo è stata forse detta l’ultima parola sull’Uomo di Ceprano? In paleontologia questo non è quasi mai vero, e ciò vale anche per il nostro Argil. Oggi però la tecnologia associata alla ricerca può aiutarci ad aggiungere qualche tessera in più al nostro puzzle.
Il fossile è attualmente conservato a Tivoli, presso il Servizio di Antropologia della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, alle cure dell’antropologo Mauro Rubini. «Sicuramente scoprire che il cranio è più giovane di quanto si pensava rende tutta la ricerca molto più interessante, perché allarga il nostro orizzonte evolutivo; mentre diminuisce la possibilità che si tratti di una specie a sé, perché con il ridursi dell’intervallo temporale si amplia la variabilità.
Ma ci sono ancora molte lacune da riempire», dice Rubini. «Abbiamo in progetto di sottoporre il reperto a tomografia sincrotonica presso la Synchrotron Radiation Facility (ESRF) di Grenoble, o all’analoga struttura di Trieste, per due ragioni. La prima è rivederne lo stato patologico complessivo: il cranio presenta ad esempio una frattura, anche se probabilmente non fu quella a causare la morte dell’individuo. Inoltre, il fossile potrebbe essere stato deformato dalla pressione sul sedimento. La seconda è accertare che la morfologia resa dalle varie ricostruzioni e restauri sia corretta, che sarebbe un buon passo avanti per attribuire il reperto a un contesto evolutivo il più attendibile possibile. Il fossile è stato ricostruito più volte, ma neppure la ricostruzione attuale è definitiva, ci sono ancora parti che non coincidono.
Frutto della deformazione? Forse. La tomografia al sincrotone ci permetterebbe di poter “rimontare” il reperto virtualmente, senza correre il rischio di danneggiare ulteriormente il fossile prima di arrivare a una ricostruzione definitiva».
E questo metterebbe fine a ogni dubbio? «Ancora no», risponde Rubini. «Nelle nostre analisi spesso non teniamo conto della grande variabilità che c’è all’interno della stessa specie. Provi a immaginare quanto sono diversi tra loro un pigmeo e un Masai: sono entrambi sapiens, eppure presentano morfologie diversissime. Non potremmo certo basarci su un singolo cranio di pigmeo, magari neppure completo, per trarre conclusioni su un’intera specie.
Ma c’è un’altra cosa che stiamo tentando di fare, ed è cercare tracce di collagene, cioè di materiale genetico, nel fossile, o almeno una gamma di isotopi stabili che ci permetta di stabilirne la dieta. L’analisi del materiale genetico da reperti fossili è stata possibile di recente con i neandertaliani, ma non si è mai riusciti finora su un reperto così antico, anche se la biologia molecolare sta facendo passi da gigante. Ecco, se questo tentativo avesse successo avremmo sicuramente molti meno dubbi sulla vera identità di Ceprano».
Ed è proprio a questo che sta lavorando Olga Rickards, professore di Antropologia molecolare all’Università di Roma Tor Vergata dove dirige il Centro dipartimentale di antropologia molecolare per lo studio del Dna antico; ma anche titolare con Gianfranco Biondi di un seguitissimo blog di paleoantropologia, Darwinpunk.
«È ancora molto presto, ma non possiamo escludere di poter ricavare da Ceprano qualche informazione di tipo genetico. Le prime indicazioni sembrano positive», dice Rickards.
«Finora ad esempio è stato possibile ricostruire quasi il 60 per cento dell’intero genoma neandertaliano; ma parliamo di materiale estratto da reperti che hanno 38-44 mila anni, e che comunque ha cambiato per sempre il nostro modo di pensare ai Neandertal. Abbiamo poi il sequenziamento dell’intero genoma estratto dalla falange di un antico ominino rinvenuta nella grotta di Denisova, in Siberia meridionale, e datata 30-50 mila anni fa». Molto più recenti, quindi, dell’Uomo di Ceprano.
«Sì, ma queste ricerche ci dicono qualcosa che rivoluziona il modo in cui siamo stati abituati a leggere la storia del popolamento del continente eurasiatico», spiega Rickards. «I cosidetti denisoviani – che non sono sapiens, e neppure neanderthalensis – hanno poche decine di migliaia di anni, ma il loro DNA rivela che la loro origine filogenetica è molto più antica: si sono differenziati circa 650 mila anni fa. Il quadro non è ancora completo, ma sappiamo che quella delle nostre origini è una storia di grande variabilità e di mescolamenti, non quella lenta inesorabile marcia di una specie che soppianta l’altra fino all’avvento dell’uomo moderno».
E chissà che tra qualche anno non sapremo finalmente con certezza dove si colloca, in questo puzzle che è la storia dell’uomo, quel cacciatore di elefanti di 400 mila anni fa.