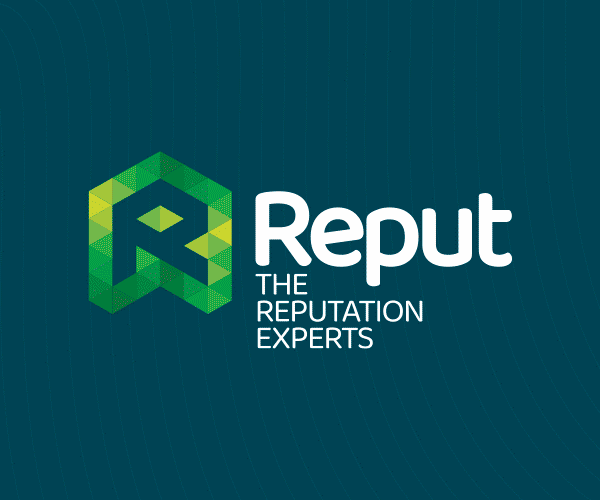La penultima serata della IV edizione del Festival della Filosofia e un tema cruciale: cosa ha fatto la tecnologia al lavoro. E cosa ha fatto scordare all'uomo
Le aveva sussurrate al direttore artistico Fabrizio Vona, poi ha preso il microfono e le ha ripetute alle persone. Parole forti che rimettono a terra i pensieri. Uno dei presenti al chiostro di Sant’Agostino di Veroli nell’ambito della penultima serata del Festival della Filosofia ha rotto un tabù. Un tabù che non esiste se non nelle menti piccole di chi fa del sapere un muro invece che un ponte. Tabù cretino, ma pur sempre tabù.
Ed all’improvviso a Veroli è accaduto un piccolo miracolo di normalità. In Emilia Romagna gli operai vanno all’opera a sentire Verdi e riconciliarsi col bello, a Veroli usano la filosofia nel verso giusto. Che non è quello di trovare risposte, ma di farsi domande. E quell’uomo ha fatto rotolare le sue parole come un macigno: “Ho lavorato 40 anni alla Klopman e queste vostre riflessioni andrebbero portate nelle fabbriche. Fatelo capire davvero quello che avete detto stasera qui. E fatelo capire a chi dovrebbe ascoltarlo e trarne un insegnamento ed una condotta”.
Il tema della serata di una kermesse voluta, pensata e messa a regime dalla consigliera alla Cultura Francesca Cerquozzi era in scia a quello guida. Ruvido, ostico, irrisolto come solo le questioni in cui l’etica è sotto sfratto sanno esserlo. “Tecnica, lavoro, cura” nel contenitore grosso di una quarte edizione che ha messo la spunta sotto “La tecnica e l’umano”.
Lo spettro dell’alienazione: produrre e basta

Antonio Manfreda insegna Filosofia Teoretica a Tor Vergata ed ha messo in tema a giogaia di una prosa essenziale, esaustiva e che ne sdoganasse la corazza sapienziale. L’approccio è stato quella del lavoro come chiave di volta delle attività umane. Lavoro declinato nel tempo, nello spazio e nelle insidie che esso ha generato.
Quali insidie? Quelle che hanno portato all’eccentricità di chi il lavoro lo fa: l’uomo. Prima, in un excursus che ha visto citati Pometeo e i tragici greci, noi eravamo centrali a ciò che facevamo. Del lavoro eravamo unità di misura. Oggi invece per parlare di lavoro e della sua profondità di incisione sulla vita dell’uomo bisogna aprire una parentesi.
Prima che arrivasse la tecnologia ad aiutare ma anche a mettere setacci più stretti i due viaggiavano appaiati. E si governavano vicendevolmente. Lo scopo era analizzare un fenomeno senza alienazioni, senza l’asservimento alla sua sola finalità produttiva.
E quella finalità ha messo l’uomo al centro di un tritacarne che nel pensiero occidentale ha dovuto produrre anticorpi. I sindacati, le lotte per i diritti, le istanze del singolo in lotta perenne con le finalità di categoria.
La tecnica: o ponte o minaccia

Un lavoro che dunque dopo la spiritualità che gli toccava per genesi oggi deve riappropriarsi della sua etica primigenia. E deve farlo immerso nel paradosso di una tecnica tiranna che in Occidente lo strappa via da questa sua nuova esegesi. Il chiostro di Sant’Agostino di Veroli ha quindi contenuto il tentativo di spiegare il lavoro come attività umana e la tecnica come accelerante della stessa. Uno straordinario incentivo che però contiene il germe di aberrazioni spesso insanabili. Attraverso questa lettura il lavoro appare come la medicina per guarire da un’esistenza che vive di continue incoerenze.
Un mastice per sanare umori, svolte e magma emotivo di un animale superiore conteso tra Apollo e Dioniso. Cosa chiede oggi il lavoro all’animale uomo e cosa impone il progresso tecnologico a chi del lavoro avesse ancora una concezione etica? La tecnica non è solo un ponte fulmineo per rendere il futuro presente, è anche una minaccia a ciò che l’uomo ha il diritto di essere. Perché la catena di montaggio aliena e disambigua i cardini della vita, e perché il lavoro dovrebbe migliorare e mettere a regime la vita, ma mai comprenderla tutta uccidendone la singolarità.
La professoressa Giuseppina De Simone, docente di Filosofia della religione presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, ha aggiunto un apparente “corpo estraneo”. Come nelle ostriche, dove per avere un gioiello si deve prima inserire un elemento alieno. E paro paro come nel pensiero, dove la lucentezza delle sue epifanie è sempre figlia di stimoli, mai di dogmi. Per lei riflettere ed interrogarsi sul rapporto tra tecnica e lavoro significa anche concepire un piano apparentemente alieno. Un piano come quello della “cura”.
La “cura” per ritrovare l’etica del lavoro

Il quotidiano e il fare sono minacciati o semplicemente accompagnati da una caducità da cui ci si deve difendere. Ecco, la cura, di cui la docente ha dato menzione su due piani: è la spiritualizzazione del lavoro. Diciamola come gli studiati. Una dimensione rituale dell’attività produttiva diventa cura dell’umano, di quell’elemento soggettivo che la tecnica ha sottratto brutalmente dall’equazione.
Ma la tecnica è una delle forme del male o un tipo di medicina? La cura come accuratezza del fare e finitezza del costruire è il simbolo del “contratto etico” che esiste tra l’uomo e ciò che è chiamato a produrre. Perché fare bene le cose significa far bene a chi le cose le fa.
La tecnica è efficacia e la sua evoluzione continua è stata benedizione, tuttavia essa non deve diventare incentivo all’alienazione.
Due piani dunque: la cura è anche attenzione verso la propensione del datore di lavoro a dare risposte ed accoglienza alla dimensione umana. E il lavoro, secondo Max Scheler, non può prescindere da bisogni e desideri del soggetto, dell’individuo. Lo scopo è altissimo, a volte irrealizzato: ascoltare per scongiurare il dominio cieco del lavoro disumanizzante.
Una possibilità: l’orgoglio improduttivo

E con esso la miopia della sudditanza, dell’assoggettamento e della prevaricazione. Lì, tra le pieghe dell’orgoglio e della prevaricazione succedono cose che non dovrebbero succedere. Che il lavoro umano muore, il lavorio della tecnica incede e gli spazi di fragilità non trovano l’interfaccia dell’ascolto. Accade dunque una tragedia immane paventata da Simone Weil.
Comprendere senza mai superare il limite significa riportare il lavoro alla dimensione della creatura che deve farlo. Farlo mentre vive e fa altro, non farlo solo per vivere.
E permettere ad un uomo che sta ascoltando quei concetti di capire che sì, quelle cose andrebbero dette nelle “fabbriche”. Dove l’uomo ed il lavoro, per chi un lavoro ce lo avesse, sono stati tagliati in due e separati dalla spada del profitto. Che della tecnologia non ne ha fatto spunto di riscatto etico, ma occasione per arruolare un sicario. Un assassino prezzolato dall’indifferenza che ha pugnalato a morte l’umanità del lavoro.