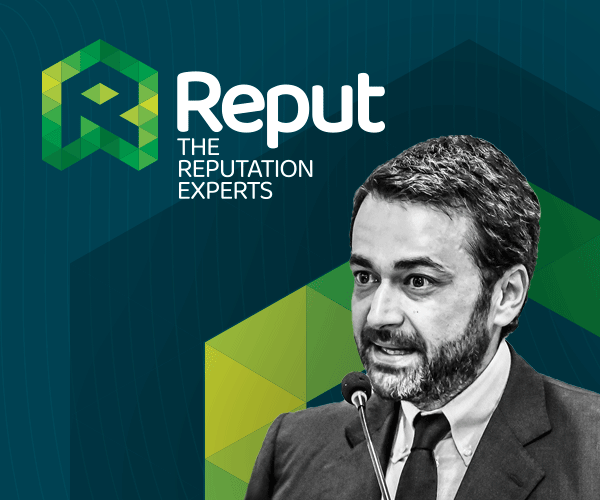di LAURA COLLINOLI
Giornalista temporaneamente a riposo
La prima volta che lo senti avverti quasi un sussulto, un colpo allo stomaco. Come se qualcuno ti avesse scosso o addirittura colpito. In maniera forte, brusca, insopportabile. Oppure come un odore strano che ti arriva all’improvviso su per il naso. Lo senti, ti penetra nelle radici, è sgradevolissimo e non sai come liberartene, anche perché magari gli altri si sono nel frattempo assuefatti e non lo sentono più.
La prima volta
La prima volta è terribile! Ma lo è anche la seconda, la terza. Lo sono tutte. Perché io non mi abituerò. No che non lo farò, perché non voglio abituarmi.
Ministra! Non minestra, ma ministra! Avete sentito bene! Sindaca, assessora, consigliera, avvocata, ingegnera, architetta!!! Architetta no, perché per lo stesso principio per il quale ci si ostina a dire sindaca, architetta potrebbe essere discriminante perché contiene la parola tetta. Sessista e offensivo. Non si può. Gli architetti donna se ne facciano una ragione, continueranno ad essere chiamate così. Buon per loro, come pure per me. La mia qualifica professionale è quella di giornalista. Poveri colleghi uomini, a cui in futuro ci rivolgeremo con il titolo di giornalisto.
È l’antica legge della A e della O per i nomi femminili e maschili. Poco importa se Andrea, in Italia, sia un nome prevalentemente maschile. Per non parlare di Irene, Selene, Mariele, Samuele, Daniele, Emanuele. Evidentemente inclassificabili. Perché funziona così. Bianco o nero. Eppure il latino ci ha insegnato così bene il neutro.
Il dibattito è apertissimo e il mio stesso ordine professionale ha dato indicazione per l’utilizzo di un nuovo linguaggio di genere. Perché, dicono, è un fatto culturale e si comincia anche da qui.
Non interessa a nessuno se stravolgiamo la lingua italiana con termini di una bruttezza disarmante, che la mortificano come e quanto i segni matematici al posto delle preposizioni e forse addirittura di più dei kappa gettati a caso al posto di chi o che.
Oltraggio alla lingua
Povera lingua italiana. Oltraggiata in nome della parità di genere. E ci mancherebbe che non debba esserci, ma non a discapito di altro. Nel caso specifico in spregio alla musicalità della nostra lingua. Attaccata su ogni fronte, ridicolizzata da un nuovo e preoccupante analfabetismo, vituperata da chi non la considera nella sua sacralità ma solo e soltanto come mezzo di comunicazione. Per quella, figuriamoci, basterebbero anche i semplici gesti.
E poi servisse, fosse utile. Ecco. Siamo sicuri che tormentare la lingua italiana possa portare ad una concreta, ripeto concreta, parità di genere?
C’è un bellissimo articolo della nostra Costituzione, almeno fino a quando la nostra carta ci sarà. Naturalmente speriamo ancora per molto. È il numero 37 e dice che la donna che lavora ha gli stessi diritti e le stesse retribuzioni dell’uomo che lavora. E c’è scritto pure che le condizioni del lavoro debbano anche assicurare che possa svolgere il suo ruolo di madre con una speciale e adeguata protezione. È scritto proprio così, speciale e adeguata protezione.
La legge esiste e però è inutile negarlo, non funziona così. Ed è innegabile. Perché le retribuzioni degli uomini sono più alte, così come sono generalmente più prestigiosi i posti di lavoro che occupano. E poi perché è recente una legge che bandisce le cosiddette “dimissioni in bianco” ma queste esistono ancora. Perché età fertile spesso vuol dire lavoro precario. Più precario degli altri. Perché quando si torna a casa da una maternità, non vige quel principio di speciale e adeguata protezione sancito dalla Costituzione, ma bene che va si è perso un treno, se non un paio. Un treno che magari non passerà più.
E poi il Fertility Day
Il discorso è lungo e subentrano concetti come rete assistenziale e opportunità di lavoro. Vere, reali, concrete, dalle quali prende forma realmente quell’articolo numero 37. Altro che la fregnaccia del fertility day, che del resto come tutti gli inglesismi utilizzati dalle istituzioni si traducono spesso come “fregatura certificata”, giusto per utilizzare un eufemismo!
Però tranquilli, ora cambierà tutto chiamando la ministra che avvertirà la sindaca che lo dirà all’assessora per poi passarlo alla consigliera. Mah… che finaccia!
E non venite a dirmi che è questione di abitudine e che la lingua è in continua evoluzione. Questo è vero, ma ci sono dei punti fermi che restano tali. Sempre e per sempre. L’uso dell’acca, o della mutina che dir si voglia, ha le stesse regole dal volgare in poi. Da subito dopo “Sao ka kelle terre…“, quando hanno capito che il kappa andava sostituito con altro.
La mutina, oltre che per le esclamazioni, si utilizza nelle voci del verbo avere. Ma non fate come una mia compagna delle scuole elementari, che scrisse “Io vado ha casa” e, al rimprovero della maestra, le risposte tutta risentita “mae’, io la casa la tengo!“.