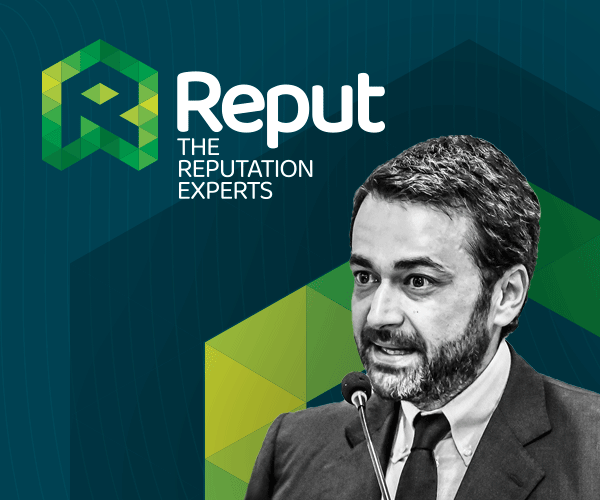Tutto è iniziato con qualche colpo di tosse e finirà con una guerra che ci lascia macerie invisibili e un senso di vuoto. E una scommessa tutta da giocare...
Tutto comincia con un colpo di tosse. Distratto, lontano. È inverno e non sembra diverso dagli altri. Sono appena cominciati gli anni Venti e a chiamarli cosi sa di strano, perché pensi a quelli di cento anni prima, gli anni ruggenti, scapestrati, l’età del jazz, le suffragette, la generazione perduta, che scappa frenetica dai ricordi della Grande Guerra e corre verso un’altra, drammatica, follia. Ti chiedi come saranno questi e cosa ti lasci alle spalle.
Non c’è una guerra, piuttosto un senso di vuoto, qualcosa che fatichi a decifrare, come un girare intorno senza sbocchi. È un passato che non porta da nessuna parte. C’è una calamita che ti trascina indietro, vecchi discorsi, parole vuote e ancora le stesse paure, con questi e quelli che urlano esattamente come nell’altro secolo. L’unica differenza è che allora scommettevano sul futuro e hanno perso. E tu? Tu chiudi gli occhi e vorresti dormire, sognare, forse. È che tu il futuro non lo vedi e non si può scommettere sul nulla.

I colpi di tosse diventano due, poi tre e ancora. Sarà un’influenza. Gira. È come se qualcuno stesse bussando con insistenza alla porta.
Non è quella solita da fumo. Non passa e ti arriva direttamente dai polmoni. Ci canti sopra una canzone di un Vasco Rossi malinconico. «Vivi in bilico e fumi le tue Lucky Strike. E ti rendi conto di quanto le maledirai».
Dicono che in Cina ci sia un nuovo virus. Francamente te ne freghi. Leggi qualcosa senza passione qua e là. Non è per cinismo o strafottenza. È ignoranza o una di quelle notizie che ogni tanto ti arrivano catastrofiche all’orecchio e poi non ti toccano. Restano lì, lontane, in qualche cantuccio del mondo dove ancora non ti è capitato di mettere piede.
La variante maledetta
Wuhan nella tua testa è un pupazzo rosa, come il cane di Bim Bum Bam, quello che parlava con il primo Bonolis. Wuhan come Uan, per quella buffa assonanza delle parole. I virus arrivano, poi fanno un po’ di allarme, se ne vanno e nessuno li vede. Ebola, aviaria, Sars, Mers sono tutti nomi che conosci ma non ti hanno messo davvero paura. Non li hai mai sentiti sulla pelle. È un po’ come urlare «al lupo al lupo» e sì, insomma, non ci credi. Questo nuovo è un coronavirus. Te lo immagini, non sai nemmeno perché, con la faccia da cartone animato di Giovanni Senza Terra nel Robin Hood della Disney. Ti fa pensare alle tasse.
La tosse prima o poi passerà. L’unica cosa che ti preoccupa sono le coincidenze della storia. È un modo ingenuo di cercare certezze. Gli anni Venti cominciano con l’ultimo giro di valzer della «spagnola». È il colpo di coda della nera signora con la falce. Cinquanta milioni di morti in ogni angolo del mondo. Il virus era una variante del H1N1, lo stesso ceppo di una normale influenza. Non si è mai capito perché fosse così cattivo: una mutazione particolarmente incacchiata.

È qui che, incuriosito dalla metamorfosi e stregato da Ovidio, incroci una parola cruciale: spillover, un balzo più in là, un salto oltre la specie. I virus lo fanno spesso, per sopravvivere, per cercare nuovi ospiti, con tentativi ed errori, ostinati e con la furbizia di Ulisse. Quando l’abbordaggio è dall’ animale all’uomo possono cominciare i guai. È quello che è successo, di nuovo, in Cina. Forse in un mercato delle carni. Si parla di pipistrelli, di una tappa sugli zibetti e poi eccolo qua. Il nuovo coronavirus, battezzato Sars-Cov-2, è un perfetto sconosciuto. Non sappiamo nulla di lui, come si muove, la sua forza, come e dove colpisce, se torna, se una volta sconfitto dagli anticorpi si resta immuni. Questo virus è Nessuno. È per questo che farà danni.
Nella notte del festival
La tosse si è smorzata. Batte sottovoce. In tv la sera c’ è chi guarda Sanremo. Si parla delle mascherate di Achille Lauro. Ma chi ha vinto? No, non te lo ricordi più. Il festival però tiene banco, molto di più di quella coppia di cinesi arrivati a Malpensa con un viaggio organizzato il 23 gennaio, in giro per l’ Italia in pullman fino a Roma. Si sentono male prima di partire per Montecassino e finiscono allo Spallanzani. Sono della provincia di Wuhan e, sì, hanno il virus. È lui. È in Italia.
Strana questa storia. Se ne chiacchiera, un po’ inquieti, però non fa davvero paura. Il virus è un contorno. L’attenzione è tutta sul razzismo. C’ è chi dice che bisogna chiudere le frontiere a chiunque provenga dalla Cina e chi corre ad abbracciare tutti i cinesi che passano per strada. È il codice binario di ogni discussione: on o off. Rosso o nero. Non si sfugge. Non ci sono sfumature. Non c’ è spazio per una visione quantica della vita. O stai di qua o di là.
Tutto questo però non è reale, perché tra lo zero e l’uno ci sono infinite possibilità. C’è l’ universo. C è la legge e il caso. C è Dio che qualche volta, di nascosto, gioca a dadi. È che se vivi solo di on e off te lo dimentichi. Il quantico è solo un punto impazzito, una trottola che si accende e si spegne e non riesce a fermarsi, accasarsi. È un errore di sistema.

Poi accade. Accade qualcosa che zittisce tutte le certezze. Non ci sono più coordinate e perfino il navigatore della tua auto continua a ripetere ricalcolo, ricalcolo, ricalcolo, come impazzito o spaesato. Nessuno si ritrova più. È il 21 di febbraio, quasi alla fine di un mese bisesto, e sulla mappa si illumina il nome di Codogno.
È una cittadina di sedicimila abitanti, messa lì in mezzo tra Lodi e Milano. Qualcuno sostiene che il nome venga dalle mele cotogne, altri dal console romano Aurelio Cotta, un antenato della mamma di Cesare. È qui che si acquartierano i lanzichenecchi e ci portano la peste. Era passata prima per Milano. È quella manzoniana. È qui che un’ anestesista si fa venire in testa una domanda: e se fosse coronavirus? C’ è un uomo giovane, forte, robusto, che si allena per le maratone e gioca a calcetto, con una strana polmonite. Non si riesce a curare. Non è mai stato in Cina e quindi non è sospetto.
Il protocollo dice che non si fanno tamponi senza un ragionevole sospetto. La dottoressa pensa che qualche volta i protocolli sono stupidi. Disubbidisce. Trova il Sars-Cov-2. La tua tosse finalmente non c’ è più.
L’ultimo cappuccino
La zona rossa è un fuoco di contagio. Il paziente uno è stato individuato. Chi gli ha passato il testimone? Si va alla ricerca del paziente zero. I sospetti cadono su un suo collega che è stato in Cina. Sono andati a cena una sera insieme. Non lo chiamano untore, ma lo pensano. Ti chiedi come ci si senta con questa etichetta sussurrata addosso. Sono forse io? Come un apostolo all’ ultima cena. Come un colpevole senza peccato. Come un nome sull’ agenda telefonica di un camorrista. L’uomo tornato dalla Cina è innocente. Non è lui l’ untore. È un errore giudiziario. Il paziente zero lo stanno ancora cercando.
Diranno che sotto assedio si è tutti più buoni. Non è vero. Ognuno amplifica ciò che è. I timidi si nasconderanno. I misantropi si daranno ragione. Gli egocentrici si incarneranno nel virus. I lussuriosi vedono You Porn. Gli esibizionisti canteranno alla finestra. Gli insicuri cercheranno una guida in ogni direttiva. I pessimisti ti ricordano che devi morire e gli ottimisti che andrà tutto bene. I caporali faranno i caporali. Non aspettavano altro.

Stanno lì, con l’ occhio a spiare ogni movimento, sicuri che l’ altro, chiunque altro, è un farabutto e si appostano, con la voluttà di chi non vive altra gioia che poter puntare il dito e urlare al cielo e allo sciagurato: vergogna. Non gli sfugge nessuno, quello che passa con il cane, quello che non ha la mascherina, quello che corre, quello che starnutisce, quello che sorride e soprattutto chi si ostina a sopravvivere come se nulla fosse. Il caporale ha ritrovato il suo mondo perfetto. Il potere a portata di mano, della porta accanto. Dio benedica i divieti.
Sono i giorni della distanza. Tieni il tuo prossimo a un metro da te. I bar sono ancora aperti, ma si consuma fuori ed è vietato mettere il gomito sul bancone. Sono gli ultimi cappuccini che hai bevuto la mattina a colazione. Ti manca la schiuma con il cuore disegnato sopra. I golosi si accontentano di poco.
Il tempo sospeso delle mimose
È pandemia. Il contagio è sfuggito di mano. L’ Italia brucia e gli altri ridono. È l’8 marzo, le mimose sono in fiore e da allora siamo ancora qua. Restiamo a casa, per ordini superiori, per necessità, per salvarci la pelle, per paura, per dovere, come forma d’amore. Ti piacerebbe chiamarla quarantena, perché ti ricorda Venezia, lì dove per la prima volta si sono chiuse le porte per rompere la catena del contagio.
Tutti però lo chiamano lockdown. Isolamento. Prigione. Ti sembra quasi di sentirlo il suono del lucchetto che viene giù. Tutto il mondo fuori. Tu ti rinserri e scopri che il lavoro è smart. I capelli si allungano e la barba cresce. Quelli al di là della porta sono ancora vivi?

Le immagini arrivano dall’alto e sono strade deserte e piazze vuote. E tutti raccontano sui social la vita quotidiana senza più spazio. Ti svelano la loro intimità. Questo quasi ti imbarazza, perché non ci si abbraccia, non c’ è il contatto fisico, ma il confine virtuale tra persona e persona è un perizoma. Siamo tutti avatar senza pudore.
Il tempo si è dilatato e non ha più punti fermi. Non distingui i giorni e i mesi di questa primavera di serra sono tutti uguali. È così che non riesci a distinguere i ricordi. Quello che ti resta è una giostra di immagini.
La fuga di mezzanotte dei figli del Sud che scappano dal Nord, le conferenze stampa a reti unificate dell’uomo dei decreti, il fuori onda del presidente Mattarella che si aggiusta i capelli e confessa che pure lui da tempo non vede il barbiere, il Papa che predica in una piazza San Pietro deserta e una Pasqua senza messe, gli inseguimenti con droni ai fuggiaschi, l’appuntamento alle sei della sera con la contabilità del virus, la resistenza per la resistenza del 25 aprile e tutto questo si confonde con le serie tv, le maratone di netflix, i virologi a colazione, pranzo, cena, prima e seconda serata, l’Europa in videoconferenza e tutto il calcio secolo per secolo.
Non c’è una trama. È un vortice di videoclip, perché l’unica cosa che conta è ingannare l’ attesa. È tempo che spendi per ritrovare il futuro.
Per chi suona la campana

No, non hai dimenticato la morte. Ti è stata seduta accanto tutto questo tempo. È il canto delle sirene senza sosta delle ambulanze. È la faccia di medici e infermieri che vorrebbero salvare tutti e cadono come soldati. È la voce dei vigili del fuoco che ti dice di non uscire. È il rintocco delle campane di Bergamo, dove i carri funebri sfilano come in processione, qui dove si piange in silenzio per non disturbare.
È l’ esercito che porta via le bare, e le ceneri verranno sparse nel vento in qualche angolo della penisola, senza neppure un saluto. È il mattatoio degli ospizi. È il Campo 87 del cimitero Maggiore di Milano, con sessantuno croci bianche, un nome, una data di nascita e una di morte. Lì ci sono i morti che nessuno ha reclamato.
La morte, così certa, così scontata, che mai come adesso ti sembra un’abitudine. Non è passata. Siamo ancora qui e c’è chi si sta abituando a non essere libero, come se fosse qualcosa di naturale. Non scegli, non rischi, non ti preoccupi; basta obbedire. È comodo, ma non è vita.
Tu vuoi vedere quello che c’è fuori e fuori c’è il deserto. C’è chi non riavrà un lavoro, chi non aprirà il negozio, chi lascia chiusa la bottega, chi ha alzato bandiera bianca. Il sospetto, al di là delle parole, è che nessuno verrà a darti credito o a scioglierti dai debiti, dalle tasse e dalla burocrazia.
Ti dicono che non è finita, perché neppure loro sanno davvero come fare. Non importa. Lo devi alle madri, ai padri, ai nonni. Lo devi ai morti. Non ti farai spostare il domani con un altro decreto.
È il primo maggio e c’ è da ricostruire un paese, a mani nude.