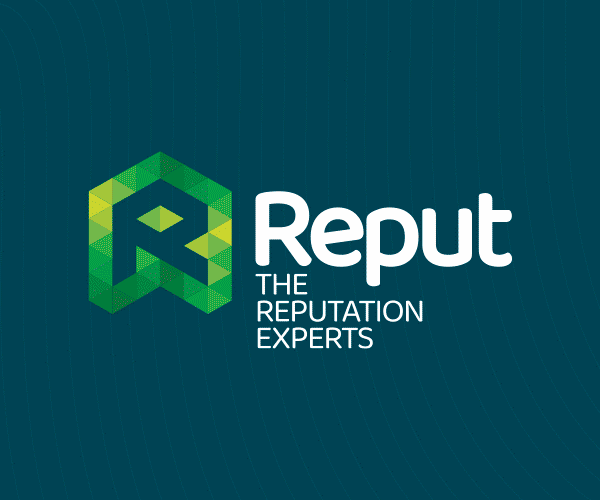Il film dell'orrore visto con gli occhi dei sovietici che entrarono nel campo il 27 gennaio del 1945: ma è un film che non è mai finito
I fanti d’assalto della 332ma divisione sovietica non erano affatto a digiuno di cose naziste, né degli orrori di una guerra che aveva impresso anche alla “non politicizzata” Wermacht un certo marchio macellaio. Loro stessi, i russi, non erano educande, solo che difendendo suolo patrio avevano avuto di fronte per lo più nemici in divisa. In guerra nessuno è francescano, specie in una guerra di ideologie. E specie se sul fronte russo Hitler ci aveva spedito anche la crème de la crème del suo sogno horror: le divisioni meccanizzate delle SS.
Il senso è che i soldati del generale Vatutin ritenevano tutti di essere vaccinati contro gli orrori del conflitto, ma dovettero ricredersi. Nessun corpo tranciato a metà dai loro “pepescià”, nessuna pila di cadaveri ad ardere con le orbite scoppiate nei capanni gelati del fronte ucraino potevano prepararli a quello che videro entrando ad Oswiecim, in Polonia, quel 27 gennaio del 1945. Il senso perciò è questo: quando un uomo avvezzo all’orrore incontra un orrore tale da fargli perdere quell’abitudine callosa e rassicurante alla barbarie allora vuol dire altro. Che lì, in quel posto, l’Orrore si è fatto Paradigma.
Cosa vide il soldato Vladimir

Le prime avvisaglie di ciò che poi si sarebbe trovato davanti le ebbe il soldato Vladimir Brylev. Era la punta di una pattuglia esplorante e da una baracca gli venne incontro uno scheletro alto poco più di un metro. Un’ombra grigia con le punte aguzze delle ossa quasi a bucare come pugnali il velo di pelle e cartilagini. E basta, in quel corpo non c’era più carne. Ci mise un po’ a capire che quella forma mostruosa e dinoccolata era la forma di un bambino a cui erano state fatte cose innominabili. Quando quella cosa gli urlò con voce stridula da una bocca che sembrava una pozza nera di sangue rappreso “non sono ebreo!” Vladimir capì. Capì che la guerra in sé conteneva altri inferni segreti e che lui non aveva ancora visto tutto.
Si piegò in avanti sulla canna traforata del PPS Sudaev, vomitò sui piedini nudi di quel fantasma trampoliere e all’improvviso ebbe voglia di scrivere a sua madre. Lo fece a sera, con queste parole: “Sono stato ad Auschwitz. Ho visto tutto con i miei occhi. Ora ti amo ancora di più. Non perdere la calma: non succederà più, mamma. Ce ne assicureremo noi”. Tutto. Con i suoi occhi. Occhi attaccati ad un cuore che urlava che quello che avevano visto non doveva succedere più. In giro, sparse per il campo, c’erano cataste di cose inanimate e coperte di polvere.
Erano scarpe, migliaia di paia di scarpe. E c’erano morti senza vita e morti con la vita ancora attaccata al corpo da un filo sottilissimo. Erano scheletrici, nudi dentro, per lo più vecchi, donne anziane e bambini. Muti. Tutti quelli che i nazisti non erano riusciti a portar via dal luogo del delitto più grande della storia appena avevano saputo che il fronte era diventato polacco e che i russi avanzavano. In tutto quei fantasmi erano 2819, altre migliaia erano state spostate di gran fretta verso ovest, per cancellare le prove e sottrarre testimoni.
Scappiamo e ammazziamo i superstiti

Durante quelle marce della morte verso Germania ed Austria gli ebrei venivano ammazzati in due modi: dagli stenti e dai tedeschi che misero a combo fretta e crudeltà. Ma i soldati di Zukov andavano spediti ed ai carnefici quel lavorio meticoloso di restaurazione di un’etica impossibile era riuscito solo in parte. Lì, oltre il cancello che proclamava che “Il lavoro rende liberi”, l’Olocausto schiuse gli occhi sul mondo e fece sapere di sé. Quei miseri superstiti lasciati al campo principale del KL, nel vedere arrivare truppe fresche, ebbero un solo pensiero: “Non è finita. Ci ammazzeranno”.
Per loro la sola presenza di una divisa era sinonimo di serena applicazione macellaia, perciò all’inizio non videro le stelle rosse sugli elmetti, i gradi diversi, né sentirono una lingua che per molti di loro era familiare. Videro soldati o nuovi kapò e ci videro la loro fine.
Lo avrebbe spiegato in un rapporto al comando divisionale il fante carrista Ivan Martynushkin: “All’inizio ci fu cautela, da parte nostra e da parte loro. Ma poi capirono chi eravamo e iniziarono ad accoglierci, a dimostrare che sapevano di non dover avere paura, che non eravamo guardie o tedeschi“.
L’inventario dell’orrore

A quel punto partirono tre operazioni simultanee: il presidio militare della zona, specie in direttrice sud-ovest, i primi soccorsi a quei poveretti e la cernita degli orrori presenti nel campo. Spesso non erano nefandezze dirette, incarnate da cadaveri in putrefazione dovunque. No, spesso l’orrore arrivava a suggerire se stesso con oggetti, ed era peggio. Oggetti umani ma senza gli uomini che di quegli oggetti avevano avuto titolarità. In giro per le baracche del campo i russi trovarono 370mila abiti da uomo ed 837mila abiti da donna.
Più di un milione di vestiti che avevano coperto più di un milione di membra, membra sparite. Un milione, un milione di persone diventate fumo, cenere segosa e poltiglia agli angoli dei vialetti. Trovarono i forni, i sovietici, e non capirono ancora fin quando non scoprirono il grasso giallo e rinsecchito a fiocchi che ne intasava le alzate e le condotte. E con esso i grossi barattoli di Zyklon B, per amarissimo paradosso sviluppato dall’ebreo Fritz Haber come insetticida cianogenetico.
Era roba della IG Farben confezionata in granuli azzurri che il mostruoso sergente Moll aveva lasciato cadere nelle camere a gas per mesi e mesi. Da un comignolo di ferro sul tetto. Senza una lacrima, senza un ripensamento, senza un rimpianto per quei rumori sordi che provenivano da sotto dopo l’inalazione del gas liberato dagli enzimi ossidanti della respirazione. Più inalavi e più morivi, scalciando i piedi a terra in un balletto nero del tuo sangue scoppiato dagli occhi.
Ammazzare ed uccidere: Dio è con noi

Ad un certo punto però i russi smisero di trovare oggetti e trovarono capelli: sette tonnellate e settecento chili di capelli. Capelli attaccati alla testa di 140mila persone, a fare i conti più tremendi del mondo. Ma quei conti qualcuno li fece: sparsi tra stanze e mucchi, ammassati come fronde di salici infernali, c’erano i capelli di un numero di persone equivalente all’intera popolazione odierna di Rimini. Avevano giocato a fare Dio, i nazisti, e per farlo Dio lo avevano rinnegato ma senza mai metterlo da parte nelle loro orazioni serali.
Nel 1933-35 nella Germania nazista la popolazione religiosa era circa per il 65% protestante e per il 32% cattolica. Il che significa che presumibilmente oltre l’80% dei carnefici di Auschwitz ammazzava il prossimo e poi, attivamente, pregava la Madonna o Dio di far star bene i suoi genitori vecchi e di preservare i suoi figli. Vecchi come quelli che ammazzavano, figli come quelli che vivisezionavano. Già, “Got mit uns”, lo arruolano tutti, Dio, per dare bontà a ciò che buono non potrà mai essere.
Il fuciliere caucasico Letnikov proprio non ce la faceva, a farsi capace di quello scenario complessivo, immensamente assurdo che, tassello dopo tassello, gli si stava formando in testa. E ne parlò alla radio del T34 con un commilitone bielorusso di retrovia, uno abituato a castrare gli orsi kodyak uccisi a fucilate da bambino, uno amico del sangue fin dall’infanzia. “Riesci a immaginare quante persone devono avervi bruciato i tedeschi? Accanto a questo crematorio distrutto ci sono ossa, ossa e mucchi di scarpe alti diversi metri. Nel mucchio ci sono scarpe per bambini. L’orrore è totale, impossibile da descrivere“.
Già, impossibile, come gli orrori che da allora hanno continuato a mettere casa nel mondo. Un mondo che ogni volta non ci crede, di cosa sia capace il mondo. E che ogni volta grida “mai più” per esorcizzare la nostra bestialità. A volte invano. Perché nel frattempo Auschwitz ha figliato la sua progenie e ci ha piantato sopra solo bandiere diverse. Con molti di noi che oggi doverosamente daranno il meglio sui social per poi tornare a dare il peggio nella vita. Già da domani.